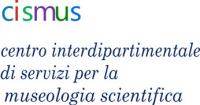Tursi, dal Rabat saraceno alla città moderna: un percorso geologico e geomorfologico attraverso storia e cultura
Tursi, piccolo comune in provincia di Matera, Capitale della Cultura 2019, si sviluppa su un territorio collinare, con altitudine variabile dai 210 m ai 346 m s.l.m.
L’arrivo a Tursi lungo la S.P.154 e/o lungo la Strada Comunale Santi Quaranta che corre lungo il canale artificiale che costituisce oggi l’alveo del torrente Pescogrosso, affluente del fiume Sinni, consente di ammirare, sulla destra, delle caratteristiche forme, risultato dell’evoluzione di una successione sedimentaria costituita da conglomerati, sabbie e argille, le “Sabbie di Tursi”.
Sviluppatesi durante il Pleistocene inferiore, in seguito al sollevamento del lembo nord-occidentale dell’Appennino meridionale (la dorsale di Valsinni–Colobraro), le Sabbie di Tursi sono il risultato dell’accumulo di sedimenti trasportati dai corsi d’acqua discendenti dalla catena appenninica. Nella loro corsa verso il mare, essi trasportavano i sedimenti prodotti dall’erosione delle rocce affioranti. L’ambiente sedimentario che li accoglieva era costituito da un sistema marino–deltizio, in continua subsidenza, che ha favorito l’accumulo di una successione spessa circa 500 m.
Il nucleo abitativo più recente, di forma allungata, si sviluppa lungo il corso del torrente Pescogrosso; mentre il centro storico, ricco di caratteristici quartieri, sale, inerpicandosi in sinistra orografica, fra stretti vicoli e ripide stradine, fino a raggiungere il punto più alto e panoramico della cittadina, la Rabatana, il quartiere saraceno, il nucleo abitativo più antico. Esso si raggiunge a piedi lungo un’ampia scalinata di lastre calcaree, a p’trizz, che segue, per circa 200 m, il ciglio di burroni strapiombanti. Questi ultimi, elemento peculiare del paesaggio, sono profonde incisioni di oltre 150 m di altezza molto simili a canyons, modellati nelle rocce, ognuna con un diverso grado di cementazione e quindi di resistenza agli agenti esogeni. La bassa resistenza di queste rocce, e l’omogeneità di alcuni banchi arenacei, hanno consentito agli abitanti di Tursi l’attività di scavo di grotte, soprattutto sui versanti lungo il percorso che collega la Rabatana al torrente Pescogrosso. Esse erano utilizzate sia come ricovero per animali di allevamento, in passato, sia come deposito, destinazione d’uso frequente ancora oggi. L’osservazione delle pareti interne di queste cavità ha reso possibile l’individuazione di molteplici elementi (strutture sedimentarie, concentrazioni conchigliari e associazioni di tracce fossili). Alcune peculiarità stratigrafico–paleontologiche della successione sono osservabili anche in corrispondenza dei sotterranei dell’antico Castello, collocati nel punto panoramico più alto, dal quale la visuale spazia sull’intero arco ionico e rende particolarmente suggestiva la visita di questa piccola cittadina lucana.
Il geoevento, organizzato dall’Associazione GeA – Geoturismo e Ambiente e dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, si svolgerà nella giornata di sabato 22 ottobre e sarà rivolto agli studenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado.
Manifestazione patrocinata dal Comune di Tursi (MT), dal CISMUS (Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia Scientifica), dalla SPI (Società Paleontologica Italiana) e dall'AIQUA (Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario).
Contattando l'organizzazione
Assicurazione necessaria, a carico del partecipante
Organizzatori:
Associazione GeA - Geoturismo e Ambiente, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
Patrocini:
Comune di Tursi (MT), CISMUS (Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia Scientifica), SPI (Società Paleontologica Italiana), AIQUA (Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario).