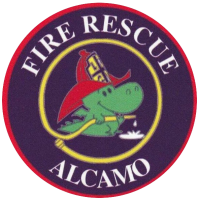Trekking nella vallata della Madonna del Ponte - Partinico (PA)
L’ idea di proporre tale Geoevento nasce dall’ esigenza di far conoscere una porzione del territorio partinicese caratterizzata da peculiari aspetti geologici, storici, naturalistici.
Lungo il percorso previsto, infatti, oltre alle bellezze naturalistiche e agli interessanti aspetti geologici sarà possibile osservare testimonianze storiche quali ad esempio: la Regia trazzera della Madonna del Ponte, il ponte di epoca romana recentemente messo alla luce dai recenti lavori di Riqualificazione e recupero, la grotta della Madonna del Ponte ed il Santuario della Madonna del Ponte meta di migliaia di pellegrini ecc, ecc.
Il trekking si svolgerà lungo un percorso circolare di circa 6 Km di lunghezza che si diparte dal Santuario della Madonna del Ponte e attraversando i due ponti sul fiume Jato e sul Ciurro Murro prosegue lungo la Regia Trazzera N. 108 denominata della Madonna del Ponte che una volta collegava i centri urbani di Partinico, Balestrate, Trappeto ed Alcamo; il trekking terminerà sempre al Santuario della Madonna del Ponte.
I due ponti, di cui il primo sul fiume Jato di interesse storico ed il secondo sul Vallone Passarello – Ciurro Murro, sono collegati da una parte della strada, ex Regia Trazzera, che era delimitata da muretti a secco tipici della tradizione siciliana rurale.
Cartograficamente L’area oggetto di studio, ricade nella:
- tavoletta dell’I.G.M.I. denominata “Balestrate” III S.O. del Foglio n° 249 della Carta d’Italia;
- nella Carta Tecnica Regionale l’area ricade nella Sezione denominata “Fiume Jato”, n° 594130.
- tra le aree che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - “Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico” descrive come aree a rischio R4, come si evince dalla cartografia allegata.
Il Ponte n. 1 (esistente sul Fiume Jato) rientra in area a rischio R2 (medio) per come indicato nella Carta del Rischio Idraulico per fenomeni di esondazione e in area P3 (pericolosità alta) nella Carta della Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione.
Entrambi i ponti ricadono in area di esondazione per manovra improvvisa degli organi di scarico di superficie e di fondo dello sbarramento Poma; mentre solo il ponte sito sul Fiume Jato (indicato negli elaborati progettuali con il n. 1) ricade in Area di esondazione per ipotetico collasso dello sbarramento Poma.
Nell’ambito della classificazione dell’intero territorio nazionale, il Comune è stato classificato nell’elenco delle località sismiche appartenente alla II categoria, con grado di sismicità S=9 (Legge n° 1684 del 25/11/1962 e successive modifiche).
L’area del bacino del Fiume Jato è caratterizzata da un assetto geomorfologico che dipende del modello tettonico delle strutture geologiche presenti e dalla differente azione degli agenti erosivi sulle diverse litologie.
I paesaggi dominanti sono due: uno prevalentemente collinare che caratterizza il bacino dalla sua porzione meridionale (le colline di Camporeale), ove il maggiore rilievo presente è quello di Monte Spezzapignate (610 m s.l.m.), fino alle falde della Dorsale Kumeta ad Est e i monti che costituiscono gli spartiacque orientale e settentrionale; uno prevalentemente montuoso caratterizzato da aspri rilievi, fra i quali spiccano le cime de La Pizzuta (1.333 m s.l.m.), del Monte Maja e Pelavet (1.279 m s.l.m.), del Pizzo della Nespola (1.086 m s.l.m.), del Monte Signora (1.131m s.l.m.) e del Monte Matassaro Renna (1.131 m s.l.m.).
A questi due paesaggi predominanti si aggiunge la piana di Partinico, al cui interno ricade l’area di progetto, il cui assetto morfologico è il risultato dei sollevamenti della piana stessa nel Pleistocene e dell’erosione di fondo dei corsi d’acqua che ha determinato il loro caratteristico andamento meandriforme incassato.
I corsi d’acqua presenti nel bacino hanno un orientamento prevalente N-W e si presentano estremamente sinuosi, adattandosi manifestatamene alle fratture impostatesi nelle arenarie pleistoceniche. Il Fiume Jato è incassato in una stretta gola a meandri, ove nessun terrazzo medio si è più conservato.
La rete idrografica si presenta con andamento “ pinnato” nella porzione nordorientale del bacino, ove si imposta su versanti rocciosi morfologicamente ripidi e caratterizzati da vallecole a V, poi evolve con andamento dendritico nelle aree caratterizzate da litologie a comportamento incoerente.
Nell’area centrale del bacino il reticolo assume un andamento sub-dendritico, poiché alle basse pendenze dei versanti si associano litologie a permeabilità differente che determinano diverso grado di erosione ad opera delle acque dilavanti.
L’asta principale si presenta a meandri incassati, con due distinti gradi di maturità evolutiva: uno stadio più maturo nella parte terminale, dopo lo sbarramento, ed uno stadio meno maturo a monte del Lago Poma dove il fondo vallivo non è minimamente calibrato.
Nella parte terminale dello Jato vi scorre parallelamente un affluente che si origina dalle colline di Grisì, impostandosi con iniziale andamento dendritico su terreni argillosi, poi rettilineo sulle litologie a comportamento marnoso dei Valloni Ciurro Murro e Passarello; in località Pantalina, a pochi metri dal ponte di progetto n. 2, confluisce nell’asta principale dello Jato.
Nell’insieme il sistema geomorfologico mostra un grado di maturità elevata dovuta alla fase di sostanziale equilibrio geomorfologico raggiunta nel corso dei tempi che, tuttavia, interventi antropici inadatti, indiscriminati o comunque eseguiti prescindendo da una preventiva indagine geologico-geomorfologica possono rendere precaria.
Durante il percorso sarà possibile osse4rvare di fatto l’ impatto antropico insistente sul territorio a causa della pre3senza dell’ autostrada PA-TP e dei piloni che la sorreggono e che rappresenteranno un punto di osservazione per evidenziare gli effetti che siffatto intervento ha avuto sul territorio.
Inoltre sarà possibile osservare la presenza di movimenti gravitativi in atto che coinvolgono i depositi marini terrazzati e che interessano le arterie stradali.
L’ assetto geologico della zona è quello tipico della porzione più occidentale della Sicilia dove affiorano estesamente diverse U.S.S. Trapanesi, quali: M.te Inici, M.te Bonifato, Rocca Busambra e M.te Kumeta.
Esse derivano dalla deformazione del Dominio Trapanese, molte di queste unità, staccate dal loro basamento, si sono accavallate sopra le marne argillose del Tortoniano inf. - Serravalliano appartenenti ai Domini Sicani e Saccensi.
Strutturalmente i Domini Trapanesi si sono sovrapposti ai Domini Saccensi e Sicani, mentre i Domini Imeresi si sono sovrapposti ai Domini Trapanesi.
L'evoluzione generale della Sicilia si colloca in quella che è l'evoluzione generale del margine continentale periadriatico a cui l'Isola appartiene.
In questo periodo si possono individuare le unità paleogeografiche di seguito elencate procedendo da nord verso sud:
• Piattaforma carbonatica Panormide,
• Bacino Imerese,
• Piattaforma Carbonatica Trapanese,
• Bacino Sicano.
La serie stratigrafica locale è costituita da:
Calcarenite di Marsala: costituita da sedimenti di ambienti marini che vanno dal litorale (da 0 a 100 metri di profondità) al circalitorale (100-200 metri); si presenta spesso in grossi banchi, con clasti prevalentemente calcarei monometrici, inferiormente tenera, superiormente più compatta e ben cementata, di colore variabile dal bianco, al giallo, al rossiccio con intercalazioni di lenti e banchi sabbioso-argillosi e argillo-sabbiosi.
Presenta spessori variabili da qualche decina di metri a pochi metri, andando dall’entroterra verso la linea di costa.
Si ha ragione di credere che nel sottosuolo del sito in oggetto lo spessore di questa formazione sia prossimo a m 50 con facies calcarenitiche e calciruditiche, a debole grado di cementazione, prevalenti su facies sabbio-argillose incoerenti.
Di regola scarsamente fossilifera presenta a tratti ricche associazioni faunistiche che non possono, comunque, essere utilizzate per una corretta datazione del sedimento.
Un’evento trasgressivo ascrivibile all’Emiliano II - Siciliano, piani del Pleistocene inferiore e medio (circa 1,5 milioni di anni fa secondo Ruggieri et alii, 1977), è la causa della messa in posto di questo deposito, discordante sui precedenti, avvenuta secondo una monoclinale immergente, generalmente, verso Sud-Ovest con un’inclinazione che nell’ambito dell’area rilevata raramente supera i 20°.
Depositi marini terrazzati (GTS): alla Calcarenite di Marsala, dopo alterne vicende che vedono la Sicilia ora in fase talassocratica ora geocratica, a seconda il susseguirsi delle crisi orogeniche, seguono i depositi arenitici del G.T.S.
Questi, che nella zona in studio trovano collocazione nella fascia altimetrica compresa tra 700 e 200 metri s.l.m., sono costituiti da calcareniti addensate, dure, a frattura scheggiosa, a stratificazione poco evidente o assente, spesso disposta in lastroni dall’aspetto bitorzoluto al cui tetto si osservano esili spessori di conglomerati poligenici.
Si tratta, in buona sostanza, di una sottile tavola calcarenitica (spesso l’azione antropica e l’erosione hanno distrutto questi sedimenti mettendo a nudo la sottostante calcarenite di Marsala) di colore da giallo paglierino a terra di Siena, diffusamente fossilifera, mediamente compatta e contraddistinta da un grado di cementazione variabile.
I clasti sono in parte di origine organica, costituiti cioè da fossili e bioclasti appartenenti a differenti specie tutte, comunque, di ambiente marino di tipo neritico, ed in parte di origine detritica.
Laddove la granulometria si fa più fine, in concomitanza con aumenti della frazione pelitica ed argillosa, il grado di cementazione dell’intero ammasso roccioso scema, talora anche in modo considerevole.
Verso la porzione basale dell’intervallo stratigrafico si osserva un incremento dei livelli calcarenitici più duri e cementati, fino a passare, secondo una superficie di discontinuità stratigrafica e di discordanza geometrica, ai depositi della “Calcarenite di Marsala”.
Lo spessore della formazione si valuta compreso tra 5 e 7 metri.
Depositi fluviali: I depositi alluvionali occupano la fascia di fondovalle dalla zona in studio. Si tratta di sedimenti che costituiscono i testimoni dell’evoluzione della rete idrografica locale, provenienti dall’intensa erosione dei rilievi più interni e poco resistenti, assunti in carico, trasportati e depositati dalle acque fluviali una volta raggiunte le zone sub-pianeggianti del loro corso.
Si presentano con una granulometria molto varia: ai livelli limoso-sabbiosi si alternano, infatti, livelli sabbiosi e lenti di ghiaia di varia natura.
L’area presenta terrazzi di origine marina costituti da biocalcarenite afferibili al Synthema della Piana di Partinico. L’intera area presenta una massiva presenza di fauna fossilifera composta da Pecten ssp., Clamys spp., Ostrea spp., coralli, briozoi, spugne, scafopodi edechinodermi.
Gli aspetti vegetazionali dell’area appartengono alla macchia mediterranea dell’Oleo-Ceratonion siliquae con le tipiche essenze arbustive come il carrubo (Ceratonia siliqua), la palma nana (Chamaerops humilis) e l’olivastro (Olea europaea var. sylvestris). Tra le essenze suffruticose spiccano i cisti (Cistus creticus e C. salvifolius), l’erica (Erica multiflora), il camedrio femmina (Teucrium fruticans) e soprattutto il timo arbustivo (Thymbra capitata) e la Fumana thymifolia. Presenti anche diverse specie erbacee come l’Euphorbia terracina e la Lobularia maritima. Particolare interesse mostra anche la flora di tipo ripariale nelle vicinanze dei due corsi d’acqua (Jato e Ciurro-Murro) con essenze tipiche come l’Equisetum ramosissimus e l’Equisetum telmateja, il pioppo nero (Populus nigra), il salice (salix sp.), il sedano d’acqua (Helosciadum nodiflorum) e il trifoglio palustre (Lotus rectus).
La fauna dell’area si presenta molto variegata con una forte componente a mammiferi tra cui la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), l’istrice (Hystrix cristata) e soprattutto il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). Tra i rettili ritroviamo la lucertola campestre (Podarcis siculus), il ramarro (Lacerta bilineata) e il biacco (Hierophis viridiflavus). Nelle vicinanze dei corsi d’acqua vi è la presenza di anfibi come il rospo comune (Bufo bufo) e il discoglosso dipinto (Discoglussus pictus). Di particolare bellezza è la componente ad uccelli come il coloratissimo gruccione (Merops apiaster), la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco tinnunculus), la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto alba) e la ghiandaia (Garrulus glandarius).
tramite modulo di registrazione
Assicurazione non necessaria
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Pro Loco Partinico
Fire Rescue Alcamo
NOPCEA SEZ. Partinico
Scuole di Partinico